 La Vergine delle
rocce di Leonardo (Louvre) data intorno al 1483, anno di
stipula del contratto con cui l’artista s’impegnava a
dipingere, per conto della Confraternita dell’Immacolata
Concezione di Milano, la pala centrale di un trittico.
La Vergine delle
rocce di Leonardo (Louvre) data intorno al 1483, anno di
stipula del contratto con cui l’artista s’impegnava a
dipingere, per conto della Confraternita dell’Immacolata
Concezione di Milano, la pala centrale di un trittico. LEONARDO L’ERETICO
Analisi semiologica della “Vergine delle rocce”
 La Vergine delle
rocce di Leonardo (Louvre) data intorno al 1483, anno di
stipula del contratto con cui l’artista s’impegnava a
dipingere, per conto della Confraternita dell’Immacolata
Concezione di Milano, la pala centrale di un trittico.
La Vergine delle
rocce di Leonardo (Louvre) data intorno al 1483, anno di
stipula del contratto con cui l’artista s’impegnava a
dipingere, per conto della Confraternita dell’Immacolata
Concezione di Milano, la pala centrale di un trittico.
Ma, a dispetto del progetto originario, che prevedeva la raffigurazione della Madonna con il Bambin Gesù, attorniati da angeli e profeti, l’artista vinciano decise, sembra di sua esclusiva iniziativa, di disattendere gli obblighi contrattuali, realizzando invece un soggetto a dir poco enigmatico, che ancora oggi arrovella le menti dei maggiori specialisti della materia, intenti a cercare di dare un senso all’ermetismo gestuale dei personaggi raffigurati.
Come scrive Giulio Argan, La vergine delle rocce rappresenta senza ombra di dubbio un quadro a chiave, cioè carico di significati ermetici più che simbolici, che Leonardo preferisce adombrare nel misterioso gioco delle forme.
Infatti, i quattro personaggi del dipinto – che paiono emergere luminosamente dallo sfondo roccioso carico d’ombra, dove, in lontananza, s’intravede lo scorrere di un corso d’acqua – colpiscono l’osservatore perché sembrano “comunicare” tra loro attraverso il linguaggio simbolico delle mani: tra il gesto benedicente alla maniera orientale della manina del piccolo Gesù e la disposizione in alto della mano aperta e un po’ contratta della Madonna, s’interpone, sintomaticamente, proprio sulla stessa verticale, l’indice dell’angelo, che punta in direzione delle mani giunte di San Giovannino.
Le tre mani, inoltre, danno l’impressione che tra loro palpiti una sorta di “circuito dialogico”, fatto di rimandi (a mo’ di ping-pong), di significanti ermetici: un circuito dialogico all’interno del quale il centro della traiettoria è rappresentato dall’indice puntato dell’angelo.
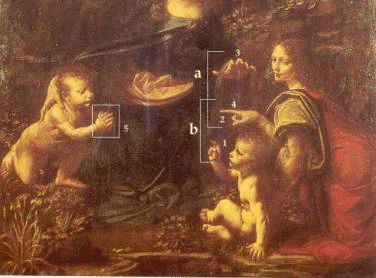 Una simile
interpretazione ci rinvia in qualche modo a una traslazione nella
pittura della forma retorico-letteraria del palindromo,
con cui si definiscono quei versi, quei vocaboli – e perché
no? – quei “numeri”, che possono essere letti
indifferentemente sia da sinistra che da destra (per esempio, la
parola anilina).
Una simile
interpretazione ci rinvia in qualche modo a una traslazione nella
pittura della forma retorico-letteraria del palindromo,
con cui si definiscono quei versi, quei vocaboli – e perché
no? – quei “numeri”, che possono essere letti
indifferentemente sia da sinistra che da destra (per esempio, la
parola anilina).
La mia interpretazione fa proprio leva sui “numeri” deducibili dalla gestualità dattilologica dei personaggi. Provando infatti a “leggere” la disposizione delle mani dall’alto verso il basso, avremo che le dita allargate della mano della Madonna suggeriscono il numero 5, seguito dal numero 1, rappresentato dall’indice puntato in basso dell’angelo: da cui 5 + 1 = 6.
Leggendo il dettaglio al contrario, cioè dal basso verso l’alto, si nota come l’indice e il medio di Gesù benedicente suggeriscono anch’essi un 5, espresso questa volta in numero romano (V); con lo stesso criterio (numero romano) leggeremo I il sovrastante indice puntato dell’angelo: da cui V + I = VI.
A scanso di equivoci, osservo che, secondo me, Leonardo offre anche una seconda lettura del palindromo pittorico: basti notare come l’indice dell’angelo punti diritto sulla posizione delle “mani giunte” di San Giovannino che, non è difficile arguirlo, alludono, appunto, al congiungimento delle cinque dita di ciascuna mano in “un” virtuale punto centrale.
Ma non è tutto. Leonardo fornisce addirittura una terza conferma interpretativa – certamente la più sconcertante e ingegnosa – che potremmo definire di tipo “geologico”, poiché riposta negli anfratti e nelle protuberanze rocciose del dipinto.
In altri termini, i significanti “dattilologici”, già ravvisati nelle rispettive gestualità delle quattro figure rappresentate, si trovano singolarmente replicate plasticamente, e soprattutto magistralmente, nelle rocce retrostanti.
1)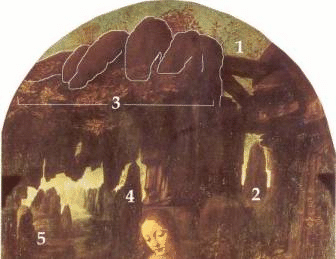 Infatti nella parte
superiore destra del dipinto è possibile notare, in visione
orizzontale, una atipica disposizione a ‘V’ delle due
travi rocciose poste sopra la nicchia, nel cui interno luminoso
si staglia un blocco monolitico, che richiama l’indice
puntato dell’angelo (ossia il numero romano I), così come
le summenzionate “rocce-travi” ammiccano alla posizione
delle due dita del piccolo Gesù benedicente;
Infatti nella parte
superiore destra del dipinto è possibile notare, in visione
orizzontale, una atipica disposizione a ‘V’ delle due
travi rocciose poste sopra la nicchia, nel cui interno luminoso
si staglia un blocco monolitico, che richiama l’indice
puntato dell’angelo (ossia il numero romano I), così come
le summenzionate “rocce-travi” ammiccano alla posizione
delle due dita del piccolo Gesù benedicente;
2) un’attenta osservazione dei singoli elementi rocciosi, che compongono la volta della grotta, ci permette di scorgere la forma delle dita della mano aperta della Madonna: il primo sasso a sinistra, l’unico disposto trasversalmente, non può che rappresenta il pollice disteso della Vergine, seguito dai restanti quattro blocchi perpendicolari, che alludono alle altre dita, rispettivamente l’indice, il medio, l’anulare e il mignolo. Identificato il numero 5, il numero 1 è ravvisabile, come nel caso precedente, immediatamente al di sotto della “mano rocciosa”, ovvero nel secondo elemento monolitico incastonato nella nicchia luminosa, disposta più o meno al centro del dipinto;
3) l’ultimo elemento ancora da identificare è l’analogo “roccioso” delle mani giunte di San Giovannino. Ebbene, lo ritroviamo scenograficamente inserito proprio al di sopra della figura stessa di San Giovannino, ossia quasi completamente al di fuori della grotta, sotto forma di protuberanze dolomitiche che richiamano, appunto, la conformazione delle dita congiunte del piccolo Battista.
Passiamo adesso ad osservare attentamente il drappo chiaro della Madonna.
Si noterà come esso sia strutturato in forma, per così dire, bipartita, nel senso che, mentre le pieghe si trovano tutte collocate nella parte sinistra, la parte destra appare invece completamente appiattita, cioè prossima alla struttura di una tavola armonica di liuto.


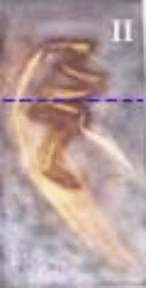 Se ruotiamo
l’immagine di 90° in senso orario, nella nuova prospettiva
il percorso curvilineo della piega centrale del drappo formerà
un numero 3 che si prolunga in basso descrivendo un numero 2,
ossia la frazione 3/2 (Tav. II).
Se ruotiamo
l’immagine di 90° in senso orario, nella nuova prospettiva
il percorso curvilineo della piega centrale del drappo formerà
un numero 3 che si prolunga in basso descrivendo un numero 2,
ossia la frazione 3/2 (Tav. II).
Entra qui in gioco il potere evocativo della metà destra del drappo che, come si è detto, richiama la forma della tavola armonica di un liuto rinascimentale.
Infatti, la frazione matematica 3/2 indica l’intervallo musicale pitagorico di quinta giusta, a sua volta riconducibile fisicamente ai 2/3 della lunghezza di una corda armonica. Siamo, dunque, ancora una volta, in presenza di un palindromo, anzi, di una frazione-palindromo, nel senso che questa può essere letta, sia matematicamente come 3/2, sia anche geometricamente come 2/3, senza cambiare di significato.
Il passaggio dalla numerazione dattilologica a quella araba non si esaurisce esclusivamente nel dettaglio del drappo chiaro della Madonna, giacché a quest’ultimo fa eco un secondo rimando perfettamente mimetizzato tra le pieghe del mantello rosso dell’angelo. Il leonardista Pedretti aveva paragonato l’angelo ad un’arpia, in quanto i lineamenti “angelici” del suo viso sono di fatto contraddetti dalla deformità del bacino, decisamente sproporzionato rispetto al resto del corpo. Ma, come vedremo, non si tratta assolutamente di una svista dell’artista; anzi, al contrario, questa apparente incongruenza anatomica “segnala” piuttosto qualcosa di ben preciso: l’abnorme fianco tondeggiante dell’angelo si configura, in realtà, come la grande testa di un doppio 6 leggibile “specularmente” a immagine capovolta: cioè, ancora una volta, un palindromo pittorico (Tavv. III-IV).
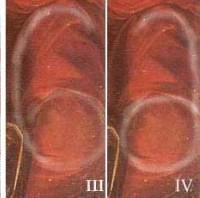 Scoperta la natura
ermetica del “significante” ‘6’, resta adesso
da individuare il suo possibile referente simbolico, giacché,
riprendendo le parole dell’etnomusicologo Marius Schneider,
“il simbolo è una realtà materiale la cui configurazione
permette a una realtà spirituale e dinamica di
manifestarsi”[.
Scoperta la natura
ermetica del “significante” ‘6’, resta adesso
da individuare il suo possibile referente simbolico, giacché,
riprendendo le parole dell’etnomusicologo Marius Schneider,
“il simbolo è una realtà materiale la cui configurazione
permette a una realtà spirituale e dinamica di
manifestarsi”[.
In cosa consiste, allora, questa sorta di “realtà materiale”, cui il numero ‘6’ dovrebbe fungere da simbolo? Ne sapeva certamente molto l’evangelista San Luca, anzi il “ dottor Luca”, quando scriveva: “Al sesto mese di gravidanza di Elisabetta Dio mandò l’angelo Gabriele in una città della Galilea chiamata Nàzaret” (Lc. 1, 26); e poi, rincarando la dose: “Ed ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e lei che era ritenuta sterile è già al sesto mese” (Lc., 1, 36).
Enunciato l’antefatto – o la “realtà materiale” del simbolo (cioè ciò che accade nel sesto mese di gravidanza) – Luca ne fa conseguire l’effetto: infatti, una volta ricevuta “grazia presso Dio”, Maria fa subito visita ad Elisabetta che così le si rivolge: “Ma perché mi accade questo, che venga da me la madre del mio Signore? Ecco, infatti, che appena il suono del tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il bambino m’è balzato in seno per la gioia” (Lc. 1, 43,44). Segue quindi il famosissimo cantico della Vergine “L’anima mia magnifica il Signore” – un vero e proprio inno alla nascita della coscienza – che Luca suggella con la seguente frase sospetta: “Maria rimase con lei [Elisabetta] circa tre mesi, poi ritornò a casa sua” (Lc. 1, 56).
Ebbene: se sommiamo il periodo dei 6 mesi di gestazione di Elisabetta con quello del soggiorno di circa 3 mesi presso di lei di Maria, otterremo 9, ovvero il periodo di una normale gravidanza. E allora: perché mai Maria decide di tornarsene a casa sua proprio nel momento in cui sta per nascere il Battista, rischiando così di mancare di riguardo alla sua parente Elisabetta? O tutto il racconto del dottor Luca allude ad altro?
La mia sconcertante “tesi-ipotesi” è che, attraverso gli episodi evangelici dell’Annunciazione e della Visitazione, l’uomo di scienza Luca abbia voluto in realtà suggellare, sia pure in forma allegorica, una sua profonda intuizione scientifica, la stessa, adottata e adattata poi a modo loro dai primi gnostici cristiani (ofiti, sethiani, barbeloti, ecc.): un’intuizione recepita a distanza di tempo (chi può escluderlo e per quali ragioni?) da Leonardo, che la immortalò subdolamente nella Vergine delle rocce, e che oggi, mutatis mutandis, definiamo con un nome scientifico appropriato, come preciserò dopo, ma di cui finora ci è incredibilmente sfuggita la sua fondamentale attinenza con il contesto narrativo dei due passi evangelici di San Luca.
Qualcuno ha ipotizzato, ad esempio, che il misterioso scenario irreale della Vergine delle rocce, fatto di rocce cadenti e contrappuntato qua e là da lembi di cielo, sia stato creato appositamente dall’artista come allusione al carattere protettivo del “grembo materno”. Del resto, l’idea stessa della caverna è abbastanza comune negli scritti di Leonardo, poiché – sempre secondo Argan – la caverna simboleggia l’interiora, che racchiude il mistero imperscrutabile di una verità irraggiungibile dall'indagine umana[2
Nel Trattato della pittura Leonardo scrive testualmente: “Tirato dalla mia bramosa voglia, vago di vedere la gran confusione delle varie e strane forme fatte dalla artifiziosa natura, ragiratomi alquanto infra gli ombrosi scogli, pervenni all’entrata d’una caverna. Dinanzi alla quale restato alquanto stupefatto, e ignorante di tal cosa, piegato le mie rene in arco, e ferma la stanca mano sopra il ginocchio, colla destra feci tenebra alle abbassate e chiuse ciglia, e spesso piegandomi in qua e in là per vedere se dentro vi discernessi alcuna cosa. E questo vietatomi per la grande oscurità che là dentro era, e stato alquanto, subito si destarono in me due cose, paura e desiderio: paura per la minacciosa e oscura spilonca, desiderio, per vedere se là entro fusse alcuna miracolosa cosa”[3].
Commentando proprio questo brano, Giovanni Gentile intuisce il desiderio di Leonardo di fondersi con il vuoto, per certi versi “vibrante”, della caverna, fino a trasfondersi in esso[4].
Le parole di Leonardo, in verità, suggeriscono una percezione “tattile” più che “uditiva”.
Leonardo, in realtà, decide di assumere una posizione di tipo “fetale”: una metafora che rinvia a un’immagine altrettanto metaforica di “utero”, cui a sua volta rinvia il simbolo della caverna. Per cui ciò che l’artista percepisce sul proprio corpo è l’eco impalpabile delle vibrazioni prodotte dal fluttuare dell’acqua marina, così come si evince dall’espressione “ragiratomi alquanto infra gli ombrosi scogli”. Orbene, tra le “varie e strane forme fatte dalla artifiziosa natura”, Leonardo – proprio quel Leonardo che della forma opposta aveva fatto, tra l’altro, anche il suo criterio di scrittura – certamente intuisce come la più misteriosa di quelle forme sia proprio quella esteriore del suo stesso corpo, colta nell’atto, per così dire, psicologico, di fusione con il vuoto palpitante di quella “Madre Caverna” che lo sta contenendo, così come il liquido amniotico lo ha una volta contenuto – a mo’ di calco – nel ventre di sua madre.
Ebbene: oggi sappiamo che, proprio durante il sesto mese di gravidanza, il feto è capace di sperimentare, memorizzandole, le sensazioni "vibro-tattili", filtrate dal liquido amniotico, in special modo quelle derivanti dalle pulsazioni cardiache materne. Tenendo conto che sempre in questo periodo si forma sulla cute del feto umano (e solamente nell’uomo) una sostanza oleosa, la cosiddetta vernice caseosa – necessaria a preservare la cute fetale dall'azione macerante del liquido amniotico –, è plausibile ipotizzare che questo evento sia in grado di scatenare, “accidentalmente”, l’imprinting nel feto, che si trova ormai completamente isolato dall’ambiente acquatico intrauterino.
In altre parole, il feto si auto-imprinterebbe “a sua immagine e somiglianza” sulla sua stessa forma corporea, ricavata nel liquido amniotico: del resto, lo spazio intrauterino occupato dal feto altro non è che la forma del liquido che lo contiene!
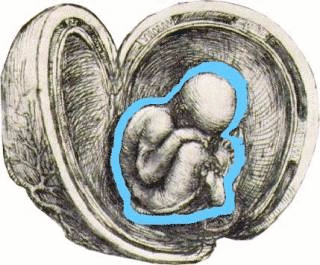 Il fatidico sesto mese di gravidanza, di cui
fa cenno nel suo Vangelo Luca, contraddistingue, perciò,
non l’apparizione del metafisico “crisma”
salvifico, bensì il più pragmatico e terreno smegma
embryonum che, interrompendo il primordiale caos
intrauterino, inaugura il processo psicologico di distinzione,
che coincide con la nascita stessa della coscienza.
Il fatidico sesto mese di gravidanza, di cui
fa cenno nel suo Vangelo Luca, contraddistingue, perciò,
non l’apparizione del metafisico “crisma”
salvifico, bensì il più pragmatico e terreno smegma
embryonum che, interrompendo il primordiale caos
intrauterino, inaugura il processo psicologico di distinzione,
che coincide con la nascita stessa della coscienza.
Ne abbiamo sentore in una sorta di riedizione del passo luchiano contenuto nell’apocrifo Vangelo dell’infanzia armeno (V sec.), in cui è scritto: “Ora, quando ebbe luogo l’annunciazione dell’angelo a Maria, la gravidanza di Elisabetta era già cominciata dal 20 di Tishri, cioè dal 9 ottobre. Da questa data al 15 di Nisan, cioè al 6 aprile, vi sono cento ottanta giorni, ciò che fa sei mesi. Fu allora che cominciò l’incarnazione di Cristo, con cui prese corpo dalla santa vergine”[5].
Ecco perché “l’apprendista gnostico” Carl Gustav Jung è giunto finanche a considerare il “Cristo” (l’Unto) come “l’archetipo del sé”, “l’essenza più profonda del processo d’individuazione”, ossia l’immagine del “fanciullo divino nato dalla compagna divina, di cui un calco dimora in ogni uomo”[6].
In conclusione, dal punto di vista psicologico, l’episodio dell’incontro di Maria ed Elisabetta non fa che rispecchiare il desiderio inconscio di ogni gestante (Elisabetta) di reinfetarsi insieme con il proprio figliolo.
Dal punto di vista gnostico il simbolo della “Madonna” (alias Barbelo, Sophia…) esprime, a mio avviso, il concetto archetipico di Prima Madre intrauterina, cioè la forma dell’acqua che si adegua alla struttura esteriore del feto. Ora a me pare di non dire alcunché di nuovo a questo proposito se, nel campo psicanalitico, Franco Fornari asserisce che “si può guardare il volto della madre [anagrafica] solo dopo essere nati e quindi solo dopo aver perso la madre [intrauterina]”[7].
Diventa quindi abbastanza scontato che, in questa prospettiva, l’atto di nascita del Battista assume carattere inconciliabile con la presenza simbolica di Maria: infatti la “perdita” della “Prima Madre” intrauterina, alias “Maria”, avviene, guarda caso, proprio allo scadere del nono mese di gravidanza di Elisabetta, cioè nel momento della cosiddetta “rottura delle acque”.
La natura simbolica, intrauterina e perciò “nascosta” di Maria, si evince ancor più dalla raccomandazione fattale da Elisabetta, sempre nell’apocrifo armeno, di rimanere assolutamente nascosta e di essere omertosa in relazione a ciò che le sta accadendo, per timore che l’episodio dell’annunciazione non susciti chiacchiere che si tramutino per lei in derisione: “Ascoltami, e segui il consiglio che ti do: ritorna in pace a casa tua, ed evita di andare e venire qua e là, ma rimani silenziosa dentro casa”[8].
Possiamo adesso meglio comprendere il significato riposto nello sguardo trasfuso di dolce malinconia della Madre di Gesù nella Vergine delle rocce: uno sguardo che sembra fissare amorevolmente le “pieghe” del drappo chiaro sospeso, “a mo’ di vascello”, nel bel mezzo del suo grande paludamento dalle tonalità abissali.
Ebbene, paradossalmente, sta proprio in questo apparentemente semplice e irrilevante dettaglio l’intimo sacrilego segreto di tutta la rappresentazione leonardesca: quelle “pieghe” sono allusive dell’esperienza ancestrale di intima compenetrazione simbolica tra la forma “femminile” dell’acqua “contenitrice” e quella “maschile” del feto in essa contenuta.
In altri termini, quelle pieghe rappresentano la testimonianza simbolica del passaggio di qualcosa che una volta si trovava lì ad occupare proprio quegli interstizi, divenuti ormai la muta effige di uno straordinario evento.
Se questa lettura è corretta, possiamo a ragione affermare che nella metafora luchiana della “Visitazione”, Maria assume il ruolo simbolico di “Prima Madre” intrauterina, assimilabile, cioè, in tutto e per tutto all’Acqua tenebrosa dei primi gnostici cristiani, oppure allo spirito della Femmina oscura del Tao, giacché, come scrive lo storico delle religioni Giovanni Casadio, il taoismo cinese, il tantrismo indiano e lo gnosticismo cristiano sono tutti esempi classici di coincidentia oppositorum, finalizzata a una salvezza mistica di fusione e identificazione con la divinità[9].
Lo stesso simbolo platonico dell’uomo sferico finisce per esprimere una “sizigie”, ovvero lo stesso archetipo ancestrale delle nozze tra madre e figlio, che ritroviamo nello hierosgamos apocalittico delle nozze dell’Agnello con la sua Madre-Sposa.
Ed è proprio in riconoscimento di questa verità, afferma Jung, che il papa ha proclamato nel 1950 il dogma della Assumptio Mariae: “Maria è unita nel talamo celeste quale sposa al Figlio e quale Sophia con la divinità”[10].
In conclusione, se da una parte la ridondanza pressoché “infinita” di rimbalzi del numero 6 nella Vergine delle rocce pare alludere alla simbologia numerica della Visitazione del Vangelo di San Luca, dall’altro lato, ancora più verosimilmente, essa lascia però presagire soprattutto una sua possibile attinenza col fatidico numero della bestia dell’Apocalisse, il famigerato “666” che, guarda caso, è anche il risultato della frazione 2/3, espresso in anni.
Si tratta solamente di una pura coincidenza? A me non pare affatto, dato che il numero allusivo “tre e mezzo” è abbastanza frequente nell’Apocalisse (vedi: XI, 3,9; XII, 6, 14; XIII, 5).
BIBLIOGRAFIA:
[1] Marius Scheneider, Il significato della musica, Rusconi, Milano 1970, p. 92.
[2] Giulio Carlo Argan, Storia dell’arte italiana, Sansoni, Firenze 1988, p. 339.
[3] Trattato della Pittura, fol. 77
[4] Cfr. Giovanni Gentile, Il pensiero di Leonardo, Sansoni, Firenze 1941, p. 25.
[5] Marcello Craveri, I Vangeli apocrifi, Einaudi, Torino 1969, p. 159.
[6] Carl Gustav Jung, Risposta a Giobbe, Il Saggiatore, Milano 1965, p. 160.
[7] Franco Fornari, Psicoanalisi della musica, Longanesi, Molano, p.41.
[8] Marcello Craveri, I Vangeli apocrifi, ibid.
[9] Cfr. Giovanni Casadio, Vie gnostiche all’immortalità, Mocelliana, Brescia 1997, p. 13.
[10] Carl Gustav Jung, Risposta a Giobbe, op. cit., p. 162.